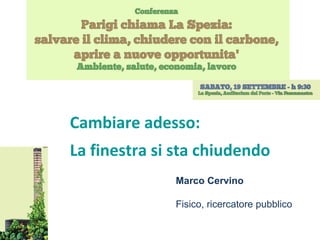
Carbone, cambiare adesso: la finestra si sta chiudendo
- 1. Cambiare adesso: La finestra si sta chiudendo Marco Cervino Fisico, ricercatore pubblico
- 3. Per maggiori informazioni: cpsl.cam.ac.uk Traduzione italiana del CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
- 4. l'obiettivo dei 2 gradi puo' essere centrato (66% di probabilità, mica certezza) se limitassimo le emissioni di carbonio a c.ca 500 Gt, da ora a sempre. (ai valori attuali costanti, sono circa 50 anni di emissioni) La quantità di carbonio che può essere rilasciata verrebbe ulteriormente ridotta se • le concentrazioni degli altri gas a effetto serra dovessero continuare a crescere; • altri elementi risultassero additivi (come ad esempio l’inatteso rilascio di gas a effetto serra dal permafrost). Year Carbon Emissions billion metric tonnes (GtC) 2013 9.9 2012 9.7 2011 9.5 2010 9.2 2009 8.7 2008 8.8 2007 8.6 2006 8.4
- 5. Thomas F. Stocker 2013 : Science Vol. 339 no. 6117 pp. 280-282 Climate Change: The Closing Door of Climate Targets
- 6. La situazione attuale: insostenibile Consumiamo quantità enormi di combustibili fossili (al mondo, ogni secondo 1050 barili di petrolio, 105.000 metri cubi di gas, 250 tonnellate di carbone) immettendo nell’atmosfera, oltre alle sostanze inquinanti che causano numerose malattie, 36 miliardi di tonnellate l’anno di anidride carbonica, gas serra che ha raggiunto la concentrazione di 400 parti per milione. Non è certo questo il modo di custodire la Terra, la nostra casa comune. http://www.energiaperlitalia.it Corollario: La situazione attuale: INIQUA
- 7. http://www.energiaperlitalia.it E’ sempre più urgente, quindi, che gli scienziati guardino oltre i confini del loro laboratorio per contribuire a compiere scelte che permettano alla nostra e alle prossime generazioni di vivere in un pianeta più accogliente, in una società più giusta e in un contesto internazionale più pacifico.
- 8. 0 200 400 600 800 1000 g/kWh CARBONE OLIO GN GN-COGEN GENERAZIONE ELETTRICA EMISSIONE SPECIFICA DI CO2
- 9. Power plant characteristics Groups: 4 x 660 MW Burned coal: 6,000,000 t/y
- 10. Ma: 16.000.000 Mt/anno di CO2 … Catturato lo 0,05% … FUMI PULITI ??
- 11. ALL’OPPOSTO: 16 Mt/annoCO2 = 1,600,000,000 alberi abbattuti = 20 000 km2 di foresta sparita
- 13. 2 GWh => circa 1000 t CO2 evitata >600 volte “cattura” Brindisi >2 volte “cattura” Brindisi
- 14. Fonte: Elaborazione ARPA Puglia (2014) sul rapporto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente sui costi economici degli effetti sanitari associati alle emissioni industriali 79 26 71 CO2 Low ‘VOLY’ High ‘VLS’ La Spezia
- 15. Secondary particulate matter originating from an industrial source and itsSecondary particulate matter originating from an industrial source and its impact on population healthimpact on population health Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12(7), 7667-7681 Cristina Mangia, Marco Cervino, Emilio Gianicolo http://www.mdpi.com/1660-4601/12/7/7667/pdf Domande di ricercaDomande di ricerca Quanto è rilevante il particolato secondario emesso da una sorgente industriale caratterizzata da elevate emissioni di gas precursori (SO2, NOx..)? E’ necessario includerlo nelle valutazioni ambientali e sanitarie?
- 17. Il particolato secondario inorganico (nitrati e solfati) presenta rischi per la salute ? Sì. REVIHAAP(WHO, 2013) + i diversi studi citati (Rif. 16, 17,18, 20, 24)
- 18. Il caso di studio: Centrale a carboneIl caso di studio: Centrale a carbone Enel Brindisi SudEnel Brindisi Sud Simulation period Year 2006 Power plant characteristics Groups: 4 x 660 MW Burned coal: 6,000,000 t/y Stack height: 200 m Stack diameter: 4×6.8 m Flue gas velocity: 20 m/s Gas temperature: 373 K Flow rate: 4×2,400,000 Nm3 /h. . Emissions (year 2006) 10,175 t/y SO2 9,282 t/y NOx 730 t/y PM Area of study characteristics 105 x 135 km2 120 municipalities 1,2 million individuals 11,571 total deaths (from National Institute of Statistics, year 2006).
- 19. Metodologia: Modellistica della dispersioneMetodologia: Modellistica della dispersione CALMET/CALPUFFCALMET/CALPUFF
- 20. Risultati simulazioniRisultati simulazioni Pm2.5 origine primaria Pm2.5 origine secondaria
- 21. Considerazioni (1/2)Considerazioni (1/2) Le zone a sud-est della centrale sono, in media in un anno, quelle più esposte alle emissioni della centrale. I valori massimi di concentrazione sono inferiori a 0,5 µg/m3 sia per il PM2.5 primario sia per il PM2.5 secondario. L’area popolata interessata dalla persistenza di particolato secondario è molto più vasta di quella interessata dal particolato primario. Il particolato primario ha il suo massimo di concentrazione ad una distanza di circa sei chilometri dalla centrale. Al contrario, a seconda delle scelte assunte nel calcolo, le diverse stime per il particolato secondario prevedono che il massimo di concentrazione giunga ad una distanza tra i dieci e i trenta chilometri dalla stessa centrale.
- 22. Xi: Concentrazioni di particolato primario + secondario derivate dalla centrale Epm; Inquinamento di fondo PM2.5 nell’area in esame generata dalle altre fonti di inquinamento quali per esempio il traffico, le emissioni portuali,riscaldamento, la combustione di biomasse.= 20μg/m3 (Arpa Puglia 2011). Ni: numero decessi non accidentali per tutte le cause. RR (Beelen et al. 2014) +
- 23. Rif.7: Beelen et al. (2014) The Lancet. Effetti dell’esposizione a lungo termine all’inquinamento sulla mortalità per cause naturali: un’analisi di 22 coorti europee all’interno del progetto multicentrico ESCAPE. RR = 1.07 (95% CI 1.02–1.13) per incrementi di 5 μg/m3 di PM2.5
- 24. Numero stimato di decessi attribuibili allaNumero stimato di decessi attribuibili alla centrale con intervallo di confidenzacentrale con intervallo di confidenza L’area di studio 105 x 135 km2 120 comuni 1,2 millioni di individui 104 decessi
- 25. Considerazioni (2/2)Considerazioni (2/2) Se si considera solo il particolato primario, sono 4 i decessi/anno che si stima sarebbero stati evitati annualmente se non vi fosse stata esposizione. Questo numero varia da 1 a 7 se si tiene conto dell’incertezza statistica associata al coefficiente di rischio adottato. Quando si considera il particolato secondario, il numero stimato dei decessi/anno attribuibili aumenta fino a 28. Tale numero varia da un minimo di 7 ad un massimo di 44 a seconda dei diversi meccanismi chimici ipotizzati, delle concentrazioni assunte per ozono e ammoniaca, ma in primis dell’intervallo di confidenza per il coefficiente di rischio adottato.
- 26. ConclusioniConclusioni Il particolato secondario originato da emissioni provenienti da installazioni industriali deve essere considerato nelle valutazioni di impatto ambientale e sanitario. L’indagine condotta nel caso di studio specifico della centrale di Brindisi ha evidenziato, infatti, che sebbene le stime siano affette da incertezza, ignorare il ruolo del particolato secondario conduce ad una sottostima notevole dell’impatto che la centrale ha sulla salute della popolazione.
- 27. I decisori pubblici e la società devono continuamente assumere decisioni. Astenersi da stime di impatto, considerate le molte incertezze promuoverebbe esclusivamente decisioni su interessi individuali senza considerare gli aspetti generali di salute pubblica. In generale, l’incertezza non dovrebbe costituire l’argomento principale per ignorare completamente le conoscenze attuali.
- 28. Cambiare adesso: La finestra si sta chiudendo Grazie per l’attenzione
Editor's Notes
- La prima potrebbe sembrare una domanda retorica, ma collegata alla seconda domanda lo è meno.
- Riprendiamo adesso, e passo al secondo punto del mio sommario, lo schema dello studio che vi stiamo descrivendo, per mettere in evidenza gli elementi che lo compongono in termini di: Dati reali raccolti (non misurati da noi ma a disposizione); coefficienti derivati da studi effettuati in altre aree; modelli di calcolo ambientale e sanitario; risultati raggiunti. Ci siamo dedicato al particolato primario e secondario inorganico. Abbiamo “alimentato“ dei modelli atmosferici e di dispersione, con dati meteorologici, orografia e uso del suolo del territorio in esame. Sono servite anche misure ambientali di PM2.5 e ozono derivanti dalle centraline disponibili. Ovviamente serve anceh conoscere le emissioni quantitative della sorgente. Questo rende lo studio specifico per la sorgente e il territorio in esame. Il modello matematico produce molte informazioni, tra cui le mappe geolocate di concentrazione al suolo degli inquinanti in esame. Queste rappresentano l‘ultimo elemento in ingresso al modello di calcolo dei decessi attribuibili, come vedremo subito dopo. Assieme a questa esposizione calcolata, servono altri dati locali, la popolazione residente e i decessi avvenuti.
- Il nostro studio, è stato già sottolineato, si sofferma sul potenziale effetto del particolato secondario inorganico. Non ha preso in considerazione altri composti secondari (particolato organico, ozono per citare i principali). Solfati e nitrati rappresentano un rischio? La ricerca scientifica sulle caratteristiche tossicologiche del particolato (dimensione, forma, composizione chimica semplice e misture, ecc.)è in forte e veloce sviluppo. La revisione effettuata dall’OMS in REVIHAAP, e gli studi che abbiamo segnalato nel nostro articolo (Rif. 16, 17,18, 20, 24) supportano con evidenze epidemiologiche e ipotesi tossicologiche la scelta di considerare il particolato secondario inorganico un potenziale rischio per la salute.
- Centrale tra le più grandi di Europa. Entrata in funzione negli anni 90. 2006 anno intermedio
- La modellistica stima e riproduce solfati e nitrati
- Io la toglierei ( vedi commenti slide 10)
- Nello studio che è stato presentato a voi oggi, abbiamo raccolto ulteriori riferimenti scientifici ancora più recenti di quelli riportati in REVIHAAP. In questa sede ne richiamo solo alcuni. Il più importante per il nostro studio è la pubblicazione di Beleen e colleghi (2014) intitolata “Effetti dell’esposizione a lungo termine all’inquinamento sulla mortalità per cause naturali: un’analisi di 22 coorti europee all’interno del progetto multicentrico ESCAPE.” Di questo studio, abbiamo utilizzato il coefficiente di rischio relativo. Per incrementi nell’aria ambiente di 5 microgrammi al metro cubo di PM2.5, è stato stimato un rischio relativo rappresentativo di tutti i 22 gruppi di popolazione in esame. Si tratta dunque di un valore con una variabilità ineliminabile, rappresentata dal cosiddetto intervallo di confidenza: una forchetta statistica con un minimo e un massimo entro la quale si confida situarsi il valore vero con una certa probabilità (95%). Questa variabilità è stata utilizzata per una valutazione dell’incertezza della stima dei decessi attribuibili.
