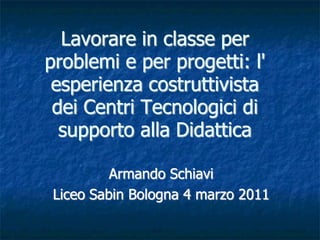
Problemi e progetti di armando schiavi
- 1. Lavorare in classe per problemi e per progetti: l' esperienza costruttivista dei Centri Tecnologici di supporto alla Didattica Armando Schiavi Liceo Sabin Bologna 4 marzo 2011
- 2. «Educational Technology is the trojan horse of education.» Roger Schank
- 3. Metodologia PBL Nella didattica per problemi e progetti la logica si capovolge: i problemi sono il fulcro e sono gli stessi problemi che spingono lo studente ad impossessarsi dei contenuti necessari a risolverli. Lepida scuola Cde PIacenza 3
- 4. Metodologia PBL Sulla dignità e quindi sullo spessore pedagogico della scelta di implementare le idee costruttiviste e socio-costruttiviste tramite una didattica per problemi/progetti si vedano i contributi fondamentali di: Howard Barrows (1985; 1992; 1993) Koslowski, Okagaki, Lorentz, and Umbach (1989) 4
- 5. Metodologia PBL L’idea che sta alla base della progettazione è che in classe non è tanto importante il prodotto finale quanto il processo. 5
- 6. Ambiente di apprendimento attivato I problemi affrontati sono legati alla realtà Il contesto dell’ apprendimento è collaborativo I docenti sono più facilitatori che erogatori di conoscenza Gli elaborati si costruiscono con l’impiego delle tecnologie L’ apprendimento si configura come un’ esperienza sociale 6
- 7. Didattica costruttivista Quali sono i suoi presupposti? Coinvolgimento attivo dei discenti nella soluzione dei problemi reali Centralità del discente Approccio orientato al problem posing, al problem solving e alla progettazione collaborativa L’ uso delle nuove tecnologie 7
- 8. Metodologia Pbl L’avvicinamento ai problemi del reale emerge dunque come caratteristica dominante di questo rinnovato approccio. Emerge il recupero in classe della complessità del quotidiano, nel rispetto dell’ambiente scuola e delle sue finalità educanti 8
- 9. Jonassen: l’identificazione dei problemi Strutturazione Dinamicità Problema Complessità Astrazione/specificità 9
- 10. Jonassen: le categorie di problemi Problemi logici Problemi algoritmici Problemi narrativi Problemi legati all’ uso di regole Problemi legati a decisioni da prendere Problemi legati a errori o guasti da risolvere Problemi diagnostici 10
- 11. Categorie di problemi Performance strategica Analisi di un caso Problemi di design Dilemmi 11
- 12. Categorie di problemi Sostanzialmente astratti e poco ancorabili alla realtà. Problemi logici Trovano applicazione nelle Logical Problems discipline che richiedono capacità di ragionamento logico. Esempio: cubo di Rubik 12
- 13. Categorie di problemi Tipicamente astratti ma ben definibili. La loro soluzione implica la definizione di una procedura formalizzabile, con Problemi algoritmici cicli di controllo. Algorithmic Problems Sono fra i problemi che si possono incontrare o impostare più facilmente a scuola. Esempi: soluzione di un'equazione; impostazione di un programma informatico 13
- 14. Categorie di problemi Sono una variante dei problemi algoritmici. La loro soluzione implica la definizione di una procedura formalizzabile, ma per essere ancorati alla realtà Problemi narrativi devono essere introdotti da una Story Problems storia. Esempio: in molta Didattica della Matematica o delle discipline scientifiche si può partire da uno Story Problem per chiarire i concetti. 14
- 15. Categorie di problemi Problemi poco strutturati. La loro soluzione implica l’applicazione di regole predefinite e gli esiti possono Problemi legati essere molteplici. all’uso di regole Rule-Using Problems Esempio: giochi di carte. Nella didattica, tipici problemi di questo tipo sono la ricerca e la selezione di informazioni in Internet 15
- 16. Categorie di problemi Problemi ben strutturati e facilmente ancorabili alla realtà. La loro soluzione implica la scelta di un’opzione fra le possibili, dalla cui attuazione Problemi dipendono un esito e una legati a decisioni soluzione definiti. da prendere I problemi decisionali Decision-Making Problems differiscono da quelli legati all’uso di regole portano, a differenza degli altri, a un esito definito Esempi: Didattica della Storia; Educazione ambientale
- 17. Categorie di problemi Sono i più comuni e i più vicini alla realtà della vita quotidiana. La complessità della soluzione può essere Problemi variabile legati a errori o guasti da risolvere Troubleshooting Problems L'approccio implica una costante attenzione alla diagnosi degli errori e una valutazione (talora sperimentale) delle possibilità alternative
- 18. Categorie di problemi Sono facilmente ancorati al mondo reale e sono simili ai problemi di controllo su errori e guasti, ma, mentre nei Problemi precedenti l'obiettivo consiste diagnostici nell'identificare la soluzione, Diagnosis-Solution Problems questi presuppongono la comparazione di una molteplicità di dati. L'esito è altrettanto definito, ma il problema è tipicamente più complesso. La soluzione presuppone l'elaborazione di una strategia.
- 19. Categorie di problemi Sono problemi complessi e fortemente ancorati al mondo reale. La loro soluzione implica Performance la comparazione di una strategica molteplicità di dati e capacità Strategic Performance logiche, diagnostiche e decisionali, secondo una strategia che va elaborata in tempo reale. Esempio: simulatore di volo.
- 20. Categorie di problemi I problemi orientati all'analisi di un caso sono poco strutturati e possono dare origine a molteplici Analisi di un caso procedure e soluzioni. Case Analysis Problems Possono non avere una relazione diretta con la realtà, pur mantenendo verosimiglianza. Esempio: in ambito giuridico, simulazioni di processi o casi giudiziari
- 21. Categorie di problemi Sono fra i problemi meno strutturati e più complessi. La loro soluzione è fortemente orientata alla Problemi di progettazione e nella design ricerca della soluzione ci sono Design Problems ampi margini di libertà di azione. Esempio: impostare un giornale o una campagna pubblicitaria
- 22. Categorie di problemi Sono problemi reali e quotidiani che implicano una scelta selettiva tra due o più alternative. Sono meno strutturati del decision- Dilemmi making, anche se Dilemmas apparentemente simili. Possono portare a esiti non definiti né definibili. Esempio: scelte politiche, sociali o etiche. 22
- 23. I due approcci Problem based learning Problema Metodo centrato sull’ allievo in cui l’identificazione e la soluzione di un problema costituiscono l’avvio e lo sviluppo del processo di apprendimento
- 24. Dal tema al problema Tema Problema Analisi delle fonti storiche Come si analizza una fonte storica? Pirandello Che significato ha oggi l’opera di Pirandello? Guida turistica bilingue Cosa facciamo oggi in città? PBL nuove forme di comunicazione Dietro ad un’immagine, una tra i giovani canzone, un film, c’è un pensiero scritto? Poesia tra colori ed emozioni Quali connessioni tra i colori e la poesia? Il silenzio del Novecento Che significato ha oggi un autore del 900? La vita e la morte Si ha il diritto di morire? Qual è il significato della vita?
- 25. Dal tema al problema Le tradizioni culturali tue, della tua Quali sono le tue tradizioni familiari famiglia e del Territorio e regionali? Cittadini del villaggio globale Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione? Viaggio nel mondo dell’alimentazione Cosa mangio realmente oggi? Nuovi modi di comunicazione tra i Come si scrive una e-mail? giovani Come si chatta? Il problema degli OGM negli alimenti Perché è importante avere una sana alimentazione? Migrazioni dall’800 ai giorni nostri Perché i fenomeni migratori ci coinvolgono nella nostra quotidianità? Il movimento simulato nello sport Perché ricorrere al movimento simulato nello sport? Le energie rinnovabili Perché ricorrere alle energie rinnovabili?
- 26. I due approcci Project based learning Metodo esperenziale basato sulla ricerca guidata e sull’ indagine (inquiry-based) e orientato alla costruzione attiva di prodotti e progetti legati al problema affrontato “La più importante innovazione pedagogica dell’ultimo ventennio” Jonassen 2003
- 27. Project based learning E’ l’approccio migliore e più completo per far acquisire ai ragazzi non solo competenze tecnologiche, ma anche la capacità di applicarle in una varietà di contesti interdisciplinari.
- 28. Project based learning «è un metodo di insegnamento sistematico che impegna gli studenti ad imparare e a sviluppare competenze attraverso un processo di ricerca estesa, strutturato intorno a domande complesse e reali e intorno a prodotti e compiti attentamente progettati.» (Buck Institute of Education)
- 29. Project based learning Il BIE in California gestisce anche il più importante repository di risorse online sul Project Based Learning: http://www.bie.org/index.php/site/PBL/over view_pbl/.org/
- 30. Project based learning I ragazzi imparano quando esplorano in modo attivo, quando creano e trovano soluzioni a problemi e quando lavorano insieme in diversi contesti sociali. Socializzare, programmare, collaborare e comunicare in quanto parte di un gruppo sono tutti elementi importanti dell’apprendimentto.
- 31. Project based learning Sostituisce integralmente la didattica tradizionale? NO, direi invece fifty-fifty. L’insegnamento diretto tradizionale va alternato alle nuove metodologie e può risultare ancora efficace per quegli studenti che stanno ancora imparando i fondamenti.
- 32. Altre caratterisitiche del Pbl Tutti i progetti sono corredati all’inizio anche da una tabella di valutazione in modo che gli studenti conoscano come saranno valutati e possanno autovalutarsi essi stessi. Ciascun progetto è legato a un’indagine o a una scoperta o a un tema che necessitano di essere esaminati
- 33. Valutazione autentica E’ uno strumento in più da inserire nella cassetta degli attrezzi dell’ insegnante Studenti valutati nell’ atto di eseguire compiti riferibili a problemi reali Feedback per l’allievo In alternativa ai metodi a selezione di risposta (v/f, a scelta multipla, etc.)
- 34. Le Rubric Strumento per descrivere e valutare prestazioni complesse (anche prodotti) in ambito educazionale
- 36. Progettare in classe Quattro sono le fasi in cui si pensa idealmente suddivisa la vita di un progetto: Ideazione Definizione esecuzione chiusura 36
- 37. Fase di ideazione Attività preliminari: la scelta del tema del progetto o dei temi del progetto, e la divisione del gruppo classe in sottogruppi “driving question”, ossia domanda guida 37
- 38. Driving question Dall’idea principale del progetto già definita si passa a riformularla in termini problematici, sotto forma di domanda, cui è difficile e complesso rispondere
- 39. Definizione - Formazione dei gruppi Progettiveri devono essere affrontati da un team Impararea lavorare in team rappresenta una life skill 40
- 40. Tecniche di formazione dei sottogruppi Scelta casuale (Random Assignement) Scelta casuale stratificata (Stratified random assignement) in ogni gruppo siano presenti almeno uno o più studenti dotati di determinate caratteristiche Medesimi interessi Gruppi che si formano da soli Gruppi scelti dall'insegnante 41
- 41. Risorse a disposizione Ambienti on line/ Piattaforme (Moodle) Presentazioni e ipertesti Mappe concettuali e mentali La ricerca (sewcom e webquest) Wiki e wikipedia Blog e RSS E-learning 2.0 Podcasting Social networks (Elgg, Edmodo) 42
- 42. Esempio di risorse permette di creare mappe concettuali attraverso l'interazione con i motori di ricerca Sewcom Usare le mappe concettuali come strumento metacognitivo per migliorare l’abilità di selezionare le informazioni con i motori di ricerca su Internet 43
- 43. Project management Per la gestione del progetto occorre un processo che consenta di organizzare in modo equilibrato la programmazione e le risorse del progetto Diagramma di Gantt: calendario delle attività in relazione ai tempi progettuali 44
- 44. Punto di partenza Brainstorming o tecniche di socializzazione 45
- 45. Esecuzione del progetto analisi dei bisogni da soddisfare e definizione degli obiettivi da raggiungere dimostrazione della fattibilità del progetto avvertire gli apprendimenti in itinere, no ad apprendimenti rigidamente predeterminati nuove esplorazioni e scoperte attraverso un percorso virtuoso personale ma guidato, seguito dallo studente 46
- 46. Esecuzione del progetto stato avanzamento Lavori (SAL), proprio della fase di esecuzione in cui sono annotate le cose di progetto fatte Progetto = indicazione per l’ orientamento Segnalazione di attitudini, formae mentis, intelligenze meno riconoscibili in un contesto di didattica tradizionale 47
- 47. Chiusura La presentazione sarà fatta in modalità multimediale, eventualmente utilizzando Power point o similari, e sarà rivolta al resto della classe, al docente o ai docenti
- 48. I deliverables Oggetti che ci aspettiamo vengano consegnati durante lo sviluppo del progetto o alla fine, testimoni di attività svolte, diventano importante strumento di misura e di controllo Rassicura l’insegnante (stessa funzione della verifica nella didattica trasmissiva)
- 49. I deliverables Non devono essere intesi come un set vincolante per tutti i progetti. Solo i progetti a più ampio respiro, quelli che si sviluppano su più mesi, possono prevederli tutti. Un deliverable è uno strumento che un insegnante può richiedere agli studenti se lo ritiene adatto alla situazione e al progetto
- 50. I deliverables Mappa concettuale per sintetizzare l’ idea del progetto Studio di fattibilità a dimostrazione che il progetto è realizzabile Elenco di attività per il conseguimento degli obiettivi (Wbs) Documento di narrazione
- 51. Il documento di narrazione Come si è arrivati alla definizione dell’idea di progetto? Quali valutazioni e scelte, quali idee scartate? Quali apprendimenti sono stati necessari? Quali ricerche? Story board Il tutto viene narrato in una sorta di diario delle riflessioni (perfetto il blog) Strumento di scaffolding (sostegno per agevolare il processo di apprendimento)
- 52. Presentazione finale momento fondamentale per allenare i ragazzi alla comunicazione imparare ad usare i vari media per esprimersi in modo più efficace skill vincente nel mondo del lavoro, in particolare nel momento del colloquio di assunzione
- 53. Presentazione finale Gli alunni di un gruppo devono decidere come distribuirsi le parti devono sincronizzarsi al meglio devono imparare a utilizzare il tempo a loro disposizione nel modo più efficace devono imparare a finalizzare l’esposizione: logica e convincente
- 54. Presentazione finale trasmettere fiducia: il tono della voce, il contatto visivo, la gestualità e l’spressione del volto saper strappare il consenso proporsi come appassionati promotori e strenui difensori del progetto fino al punto di arrivare ad ottenere l’assenso esplicito alla sua attuazione
- 55. Un esempio in aula Analizzare degli strumenti di misura della temperatura per riprogettarli con il problem posing
- 56. Problem Posing Il problem posing è un’abitudine mentale che permette di arrivare all’acquisizione delle conoscenze, attraverso la ricerca e l’esplorazione di nuove prospettive nella visione dei problemi
- 57. Analisi preliminare di uno strumento di misura Abbiamo scelto uno strumento di uso comune in casa: Il termometro clinico a mercurio quello tradizionale
- 58. Porsi delle domande sull’oggetto
- 59. 1. Perché si usa, a cosa serve? 2. Quando si usa? 3. Dove si usa? 4. Chi lo ha costruito, è prodotto da una sola azienda? 5. Quando è stato costruito? 6. Quando è stato inventato? 7. Ne esistono altri tipi? 8. Dove si compra? 9. Quanto costa? 10. Da chi è stato inventato?
- 60. 11. La parola termometro da dove deriva? 12. Quali modifiche ha subito nel tempo? 13. Nei paesi sottosviluppati c’è l’esigenza di avere il termometro? 14. Esiste in ogni parte del mondo? 15. E’ di facile manutenzione? 16. Il prezzo da cosa dipende? 17. Prima della sua invenzione con quale sistema veniva misurata la temperatura corporea? 18. Come è fatto, come funziona?
- 61. Fase dichiarativa I ragazzi elencano gli attributi dell’ oggetto in studio In questo modo si socializzano le conoscenze
- 62. Fase dichiarativa 1.E’ un tubolare 2. E’ di vetro 3. Ha il puntale di forma arrotondata 4. Il tubolare di vetro misura dodici cm 5. E’ composto da pezzi 6. I pezzi sono tre 7. Il bulbo interno è di vetro 8. Il bulbo interno contiene mercurio 9. Al bulbo interno è fissata una scala termometrica
- 63. Fase dichiarativa 10. La scala termometrica rappresenta un intervallo di temperature tra 35° C e 42° C. 11. Serve per la misura della temperatura corporea 12. La forma ci consente di posizionare facilmente lo strumento in diverse posizioni corporee 13. Il puntale è indispensabile per non ferire chi è sottoposto a misura
- 64. A conclusione della prima fase Stesura di un testo in modo che le conoscenze evidenziate vengano organizzate e sistemate; occorre utilizzare quasi esclusivamente gli attributi così come sono stati formulati
- 65. DESCRIZIONE GENERALE Omissis PRINCIPIO SCIENTIFICO DI FUNZIONAMENTO Omissis
- 66. Valutazione delle caratteristiche comparate Possiamo allargare il campo di indagine confrontando in classe più strumenti per la misura della temperatura corporea osservandoli da vicino e analizzando nel dettaglio le principali caratteristiche di ciascuno
- 67. Confronto tra strumenti diversi Tabella di confronto
- 68. Fase di riprogettazione Partiamo da una situazione problematica: siamo in un laboratorio dove si fanno delle prove sui materiali e di dover procedere alla misura della temperatura interna ad una stufa utilizzata per l’ essicazione, in modo da confrontare i dati rilevati con quanto indicato dal termostato dell’ apparecchiatura (operazione di taratura).
- 69. Definizione del problema Con quale strumento misuriamo la temperatura interna della stufa per tararla correttamente?
- 70. Problem Posing La tecnica del problem posing prevede, dopo la fase dichiarativa, una fase di negazione degli attributi che avviene ponendosi la domanda “e se non . . . ?”
- 71. Problem Posing La negazione degli attributi è un metodo molto forte per costruire nuova conoscenza Spinta ad analizzare soluzioni alternative a quella adottata per l’oggetto fisico che ci si trova davanti
- 72. Problem Posing Stimola lo sviluppo del pensiero divergente Pone il ragazzo davanti a problemi che non possiedono già una soluzione Infinite possibilità tutte da verificare Tre ambiti (materiali, forma e funzione)
- 73. Problem Posing e se non fosse di vetro? e se non fosse a forma di tubolare cilindrico? e se non fosse a punta? e se non servisse a misurare la temperatura corporea ma servisse invece per misurare la temperatura interna ad una stufa? e se…….
- 74. Problem Posing Libera la capacità di progettare senza vincoli alla fantasia Si possono concepire oggetti stravaganti che perdono la loro funzione principale, per diventare un oggetto da regalo o un soprammobile o un oggetto per l’ impiego in laboratorio (il caso)
- 75. Problem Posing Il prodotto finale ha pochissima importanza e potrebbe non esistere fisicamente, specialmente se ci si rivolge a materiali non lavorabili a scuola o a processi produttivi complessi La discussione risulta sempre molto coinvolgente e cattura i ragazzi sia in termini di attenzione sia in termini di ricerca creativa sviluppa il pensiero logico-ipotetico- creativo
- 76. Intuizione Lo strumento che serve per questa particolare applicazione non può essere inserito integralmente nella stufa ove alle alte temperature rischierebbe di subire danneggiamenti
- 77. Soluzione progettata Disporre di un termometro che può essere suddiviso in due parti: 1) Sonda termometrica flessibile e resistente alle alte temperature che sarà inserita nella stufa consentendo la misura a sportello chiuso senza alterare la temperatura interna da rilevare 2) Strumento di misura digitale con display che l’operatore tiene in mano e che fornisce il risultato sperimentale.
- 78. Ricerca sul web Esiste già in commercio uno strumento simile a quello che abbiamo riprogettato?
- 79. Ricerca sul web La ricerca dei ragazzi ha esito positivo. Ecco lo strumento di laboratorio di cui abbiamo bisogno:
- 80. Un grazie a tutti Voi e un ringraziamento particolare a Prof.ssa Maria Famiglietti Prof. Giancarlo Sacchi Prof. Enzo Zecchi
